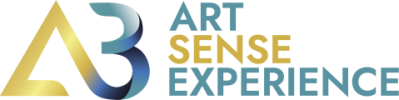D.M.C.A. : Division of Modern And Contemporary Art (“Historical Analysis and Criticism”)
Vero fiore all’occhiello dell’attività, che oltre agli innumerevoli servizi messi in campo approfondisce ulteriormente attraverso la Sua Divisione interna quelle tematiche che rappresentano i principi fondanti del MERCATO DELL’ARTE( e di cui diamo cenno secondo principi generali):
CRITICA D’ARTE
CURATELA ARTISTICA
MERCANTE D’ARTE
CATALOGAZIONE
LA CASA D’ ASTA
INVESTIRE IN ARTE (COLLEZIONISMO)
LE MOSTRE D’ARTE (L’ATELIER)
 CRITICA D’ARTE:
CRITICA D’ARTE:
La critica artistica è la discussione dell’arte visiva I critici d’arte solitamente analizzano l’arte in un contesto estetico o di teoria della bellezza. Uno degli obiettivi della critica è quello di ottenere delle basi razionali per la valutazione e l’apprezzamento dell’arte. La varietà dei manufatti artistici ha reso necessaria la divisione della critica artistica in differenti discipline, ciascuna di esse utilizza i propri criteri per giudicare le opere.
Scopri di più
Dal Seicento in poi, La critica d’arte, intesa come valutazione e interpretazione delle opere, ha avuto un punto di partenza ,grazie ai lavori di Giovanni Battista Agucchi ,l’attenzione dei critici si soffermò sulle stile dell’artista, nel tentativo di ricondurre l’immagine artistica in una traduzione letteraria. In questo secolo la personalità più eminente fu Pietro Belloni che imperniò il suo modello di critica sugli ideali classici, tenendo come riferimento i canoni del classicismo.
Durante il secolo dei lumi Denis Diderot con i suoi appunti e le sue epistole riguardanti i vari Salons, aprì le porte alla critica di attualità e all’arte impegnata. Se nella seconda metà del Settecento , Johann Joachim Winchelmann propose una mastodontica Storia dell’arte, penalizzante però nei confronti del Medioevo la stessa “era di mezzo” venne rivalutata dai critici romantici degnamente rappresentati da studiosi come John Ruskin . Nella seconda metà dell’Ottocento la “teoria della pura visibilità” consentì alla critica d’arte di compiere un passo in avanti, liberandola dai vincoli del modello di imitazione della natura e di progresso dell’arte consequenziale, e arricchendola di nuovi e più efficaci elementi interpretativi dei diversi linguaggi degli artisti. Complessivamente, sia l’idealismo e sia il positivismo influenzarono la critica d’arte ottocentesca.
Con il pensiero di Benedetto Croce sia la coscienza critica sia la concezione artistica, ricevettero un nuovo impulso, grazie alla visione dell’arte come espressione di sentimenti e al superamento della indagine filologica a vantaggio della figura dello storico e del critico. Negli anni immediatamente successivi, Lionello Venturi fu uno dei precursori della storia della critica d’arte, e di alcuni pilastri fondamentali quali la distinzione fra arte e gusto. Sempre nel Novecento si è rivelata fruttuosa la moltiplicazione di orientamenti critici avvenuta in Francia, in Inghilterra ed in America che ha sviluppato una letteratura critica sorta in tempo reale con le innovazioni artistiche.
Nella storia recente in Italia si annovera una schiera di critici e storici dell’arte contemporanea quali Federico Zeri , Levi ,Achille Bonito Oliva e di divulgatori quali Vittorio Sgarbi,Philippe Daverio, Gregorio Rossi, Daniele Rodini Tedeschi, accomunati da un professionismo mediatico, elemento indispensabile alla divulgazione dell’arte tutta del XX secolo.
 CURATELA ARTISTICA:
CURATELA ARTISTICA:
Un curatore d’arte (dal latino: cura) è un professionista che si occupa di tutti gli aspetti relativi all’organizzazione di un’esposizione artistica. Questo comprende responsabilità in merito ai contenuti, agli allestimenti, all’organizzazione, alla promozione e alla gestione finanziaria, sebbene quest’ultimo aspetto sia a volte delegato ad un ente esterno o ad un collaboratore.
Scopri di più
Il curatore può seguire diverse strategie curatoriali, seguendo una metodologia pragmatica o idealista, un approccio scientifico (basato su modelli storici) o creativo (basato su connessioni libere tra le forme d’arte). Può anche scegliere fra diversi modelli espositivi, ad impianto tradizionale o supportati da alta tecnologia, o optando per un’installazione di tipo didattico, realizzata con materiali stampati e relative schede di documentazione.
 MERCANTE D’ARTE:
MERCANTE D’ARTE:
Il mercante d’arte è il punto di contatto tra collezionisti, istituzioni, critici e gli artisti Fanno parte del mercato d’arte gli agenti di artisti, intermediari, galleristi e gallerie commerciali; si usa anche l’espressione inglese art dealer, intendendo una persona o una compagnia che in maniera autonoma e indipendente vende e compra opere d’arte.
Scopri di più
L’art dealer cerca in maniera indipendente gli artisti da rappresentare, e costruisce una rete di rapporti con collezionisti e musei ai quali gli artisti individuati potrebbero interessare.
Alcuni mercanti sono in grado di anticipare le tendenze del mercato, o a influenzarne il gusto. Solitamente si tratta di figure professionali specializzate in un particolare stile, periodo e regione. Spesso viaggiano a livello internazionale frequentando mostre, aste d’arte, e studi d’artista, alla ricerca di novità o di piccoli tesori dimenticati.
Una volta acquistata l’opera d’arte questa viene rivenduta alle gallerie o direttamente ai collezionisti. Gli art dealerche si occupano di arte contemporanea solitamente espongono le opere nelle loro gallerie di riferimento e ricevono una percentuale sul prezzo di vendita dell’opera.
Spesso i mercanti prima di iniziare la loro carriera hanno conseguito studi di storia dell’arte e lavorano come curatori, critici d’arte o in case d’asta. Per condurre la loro carriera devono avere un’approfondita conoscenza del lato commerciale del mondo dell’arte, ciò significa saper tenere il passo con le tendenze del mercato, essere informati sui gusti dei possibili acquirenti, ed essere in grado di stimare il prezzo di vendita di un’opera.
Coloro che si occupano di arte contemporanea sono spesso figure attente alla promozione dei giovani artisti e a garantire loro un mercato. Per determinare il valore di un’opera d’arte, i dealers ispezionano in maniera molto accurata gli oggetti o i quadri, confrontando dettagli e prezzi simili.
 CATALOGAZIONE:
CATALOGAZIONE:
L’importanza del testo monografico nell’ambito dell’arte contemporanea. A partire dal semplice portfolio dell’artista fino ad arrivare alla realizzazione di cataloghi di mostre personali o testi antologici, la monografia nell’arte contemporanea è sempre più uno strumento necessario non solo per la storicizzazione dell’artista, grazie ai contributi testuali offerti dalla critica e inseriti nei volumi, ma anche per diffondere, comunicare e pubblicizzare le opere nel mercato dell’arte.
Scopri di più
Il testo monografico, non necessariamente legato alla realizzazione di una mostra, è uno strumento fondamentale nel sistema dell’arte contemporanea odierno, sia per catalogare e valorizzare, storicamente ed economicamente, la ricerca compiuta da un autore scomparso, sia per sostenere e legittimare un artista vivente nel panorama collezionistico. Innumerevoli sono i casi nazionali e internazionali che testimoniano come la realizzazione di una monografia per un artista contemporaneo rappresenti ancora oggi uno strumento fondamentale di storicizzazione dell’opera, di aumento del valore dell’opera nel mercato, di appetibilità collezionistica oltre che di sistematizzazione del lavoro.
Discorso analogo vale per gli artisti molto giovani il cui valore di mercato non può essere ancora calcolato in base a parametri standard o ai passaggi in asta, in questo caso sono spesso le galleria d’arte da cui sono rappresentati, o gli artisti stessi, a investire nella realizzazione di monografie, che se da un lato servono a presentare la ricerca dell’artista a possibili compratori, dall’atro offrono uno strumento utile per mostrare le opere a critici, curatori e direttori museali, affinché i lavori possano essere inseriti in rilevanti mostre collettive o per esposizioni personali.
 LA CASA D’ASTA:
LA CASA D’ASTA:
Un’asta è il processo di compravendita mediante offerte che si conclude con la vendita dell’oggetto al migliore offerente. Nella teoria economica l’asta è un metodo per determinare il valore di un bene(commodity) che ha un prezzo non determinato o variabile. In qualche caso esiste un prezzo minimo o di riserva; se l’asta non raggiunge il minimo la vendita non avviene.
Scopri di più
L’asta è un sistema di allocazione delle risorse caratterizzato da un insieme di norme che presiedono allo scambio tra agenti economici, specificando la procedura utilizzata per determinare il rapporto di scambio, ovvero il prezzo che deve essere pagato per il godimento di un bene, un servizio o un diritto. Il prezzo in questione può essere quantificato sotto il profilo strettamente monetario oppure come oneri a carico dell’assegnatario cioè di obblighi a fare. In tal senso l’asta svolge un ruolo distributivo o allocativo a seconda dell’oggetto dello scambio; vale a dire che può essere indetta un’asta tra vari fornitori per l’acquisto di merci ma anche tra compagnie aeree per la disponibilità oraria per l’atterraggio negli aeroporti, e in tali casi lo scopo dell’asta sarà quello di massimizzare i proventi della cessione del bene (o minimizzare il costo nel caso di acquisto) o ripartire le risorse tra vari aventi diritto.
L’asta condivide con il mercato tradizionalmente studiato dalla teoria economica la caratteristica di luogo di incontro tra domanda e offerta, ma essa assume una struttura particolare e semplificata poiché tipicamente solo una delle due parti (tipicamente la domanda) svolge un ruolo attivo. Da questo punto di vista è possibile definire l’asta come one-side market.
Le aste rappresentano la modalità di scambio forse più conosciuta e studiata. Il termine asta richiama alla mente la procedura orale ascendente tipica degli enti specializzati nella vendita di oggetti artistici e d’antiquariato, ma questo è un esempio sicuramente non esaustivo delle potenzialità applicative di questo sistema. Vari tipi di merci, ma anche titoli, contratti e diritti vengono scambiati tramite aste che si tengono ad intervalli regolari secondo modalità ed in luoghi convenuti. Aste periodiche vengono ad esempio fissate dalle banche centrali per la vendita di titoli e certificati del debito pubblico.
Le borse valori funzionano tramite un’asta doppia, dove cioè la competizione è ammessa sia dal lato della domanda (al ribasso) che dell’offerta (al rialzo), fino a che si giunge ad un prezzo comune che consente lo scambio. Nel settore pubblico l’asta diventa una modalità molto diffusa per l’aggiudicazione di contratti di esclusiva nello sfruttamento di risorse comuni o di veri e propri diritti di monopolio.
L’essenza dell’asta resta tuttavia identica: mettere in competizione più agenti per l’ottenimento di una o più risorse scarse, in modo da realizzare un’allocazione efficiente. Dal punto di vista del banditore, inoltre, l’asta può essere vista come metodo di selezione ottimale della controparte dello scambio.
L’asta come meccanismo di selezione e scambio si svolge in un contesto in cui le regole sono pubbliche ed accettate da tutti i partecipanti prima che l’asta stessa abbia corso. In particolare le regole d’asta, che devono essere note e che ne definiscono il meccanismo, devono necessariamente riguardare:
L’oggetto/i dello scambio;
Le modalità di ammissione;
Il modo in cui devono essere presentate le offerte;
La regola di aggiudicazione;
La regola di pagamento.
 INVESTIRE IN ARTE (Collezionismo):
INVESTIRE IN ARTE (Collezionismo):
Quello che caratterizzò maggiormente la storia del collezionismo dell’arte del XX SECOLO fu il ruolo che ricoprirono galleristi e collezionisti. Essi furono gli attori principali per la diffusione fisica e commerciale della maggior parte delle opere d’arte di quel periodo, sviluppando un sistema finanziario dell’arte tale da poter influenzare la critica sulle nuove scoperte e di conseguenza sulla valorizzazione di molte correnti artistiche.
Scopri di più
Più tardi verso la metà del secolo l’investimento di capitale, la creazione di un sistema economico del collezionismo e la dinamicità di tale mercato permisero a banche e società di credito di investire nell’arte dando vita negli USA alle prime collezioni aziendali. Da notare come già precedentemente l’attività di grandi CORPORAZIONI È’ stata impiegata per nascita delle istituzioni museali: Rochefeller e Moma. Solo molto più tardi l’attività di alcuni artisti (critica istituzionale) si concentra sull’evidenziare i collegamenti tra il mondo dell’arte e l’economia. Un esempio di tale pratica artistica è il lavoro dell’artista tedesco Hans Haacke che nel 1970 realizza la sua opera Moma pall,con la quale sottolinea le relazioni tra Moma, il governatore Richefeller e la politica del tempo del presidente Nixon.
Si assiste poi alla nascita di una nuova forma di collezionismo sicuramente più dinamico che non si limita a seguire le tendenze del mercato dell’arte, ma le anticipa.[1] È su questo solco che si muove la testimonianza storico-artistica del collezionista italiano, Giuseppe Panza di Bluma, capace di raccogliere nel tempo una miriade di opere delle più disparate tendenze.
La mobilità dell’opera d’arte, garantita sia dai mezzi di trasporto sia dai flussi economici, insieme alla moltiplicazione degli operatori di settore, della diffusione mediatica e di un pubblico sempre più vasto favorirono la comparsa di nuovi modelli espositivi come ad esempio la fiera d’arte.Esempio di tale manifestazione è il caso di particolare rilievo della fiera di Basilea: Art Basel. Queste metamorfosi del mercato e del mondo dell’arte influirono ed influiscono tuttora profondamente nella concezione di bene artistico, alimentando così un concetto di collezionismo ambiguo e multiforme.
Nel XXI SECOLO L’investimento nel settore artistico rappresenta la sintesi tra diversi fattori: valore, cultura ed estetica. Questa sintesi appare non trasparente per via di logiche e meccanismi intrinseci del sistema dell’arte spesso speculativi e volutamente opachi. Questi elementi caratterizzano molti aspetti dell’arte e delle collezioni degli ultimi decenni del XX SECOLO e degli inizi del XXI.
Il mercato dell’arte, nonostante sia caratterizzato da inefficienza, soggettività e informazioni privilegiate, attrae un numero sempre maggiore di investimenti sia da parte dei privati, che da parte delle aziende, le quali utilizzano l’ARTE CONTEMPORANEA come strumento di marketing.Gli investimenti in arte sono definiti:
irrazionali: l’unicità delle opere e il loro valore estetico provocano un piacere non facilmente soggetto a valutazione.
alternativi: in quanto presentano una specifica combinazione di rendimento/rischio(più specificatamente ad elevato rendimento corrisponde elevato rischio e ridotta liquidità).
A partire dalle considerazioni esplicate nelle teorie di Hardy Markowitz gli investimenti in arte permettono di costruire portafogli diversificati, e attraverso tale diversificazione si migliora la performance e il rischio di portafoglio anche se si presuppone un orizzonte temporale di resa medio/lungo.
La scelta di artisti contemporanei è più rischiosa, essendo più soggetti alle mode e non ancora storicizzati; artisti già affermati invece presentano garanzie maggiori, dovute a una notorietà ormai consolidata. L’investimento in arte è tuttavia ancora considerato appannaggio di pochi, con possibilità economiche di un certo livello, oppure viene visto come una passione dispendiosa, più che una possibile fonte di guadagno.
Il rendimento dell’investimento in arte si valuta in base ai seguenti indici rappresentativi del mercato:
In particolare grazie al Mei Moses Art Index si è capito che:
il rendimento degli investimenti in arte è di poco inferiore a quello delle azioni, e superiore a quello dei titoli di stato.
la volatilita’ degli investimenti in arte è relativamente più elevata ma in diminuzione nel tempo,
esiste una correlazione molto bassa con i rendimenti delle azioni e delle obbligazioni.
 LE MOSTRE D’ARTE (l’ATELIER attività e scopi):
LE MOSTRE D’ARTE (l’ATELIER attività e scopi):
Dalla pittura alla scultura , dalla fotografia alla video arte, dalle installazioni artistiche ad elementi di disegn( arredamento, abbigliamento ed accessori), la nostra galleria d’arte può presentare opere di un singolo artista oppure di vari autori. Le opere d’arte ivi esposte possono essere frutto di: acquisti, prestito per esposizione, donazioni (quest’ultimo caso in particolare per mostre museali).
Scopri di più
Gli stessi scopi vengono perseguiti offrendo la possibilità per i visitatori di acquistare le opere esposte o alle quali il gallerista (direttore o responsabile della galleria) può avere accesso. L’obiettivo principale della nostra galleria (Atelier) comunque rimane quello di organizzare mostre aperte al pubblico, per un’azione di sensibilizzazione culturale, per favorire la conoscenza degli autori e delle tendenze artistiche e la pubblicizzazione della galleria stessa.
– Jackson Pollock
Chi Siamo
La Storia
Mission
Vision
Investire in arte
Blog
Il Network
Iscriviti
I nostri artisti
Atelier
Cataloghi
Eventi
ArtSense Experience
La filosofia
Il movimento
I prodotti
Acquista Ora
Servizi
Catalogazione Fotografica
Analisi Storico Critica
Promozione Culturale
Esposizioni Eventi
Tutti i servizi